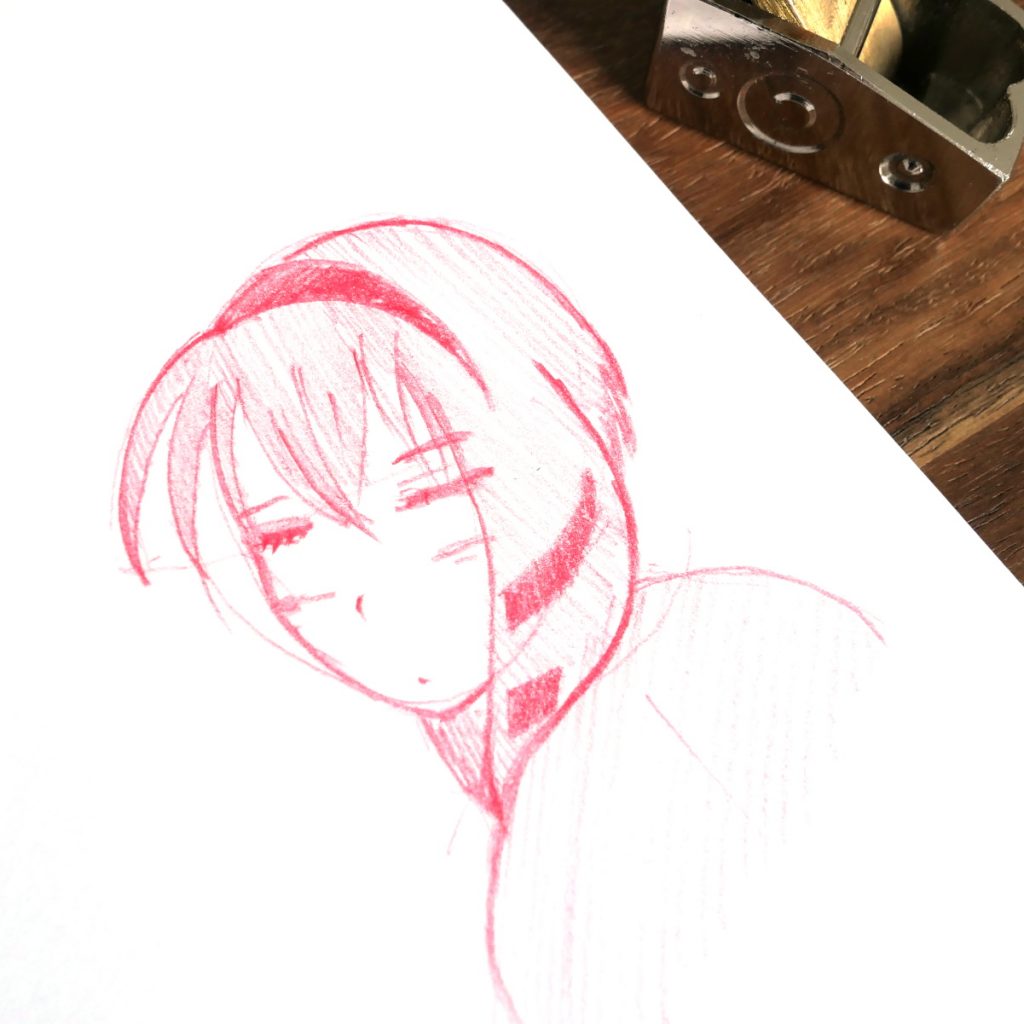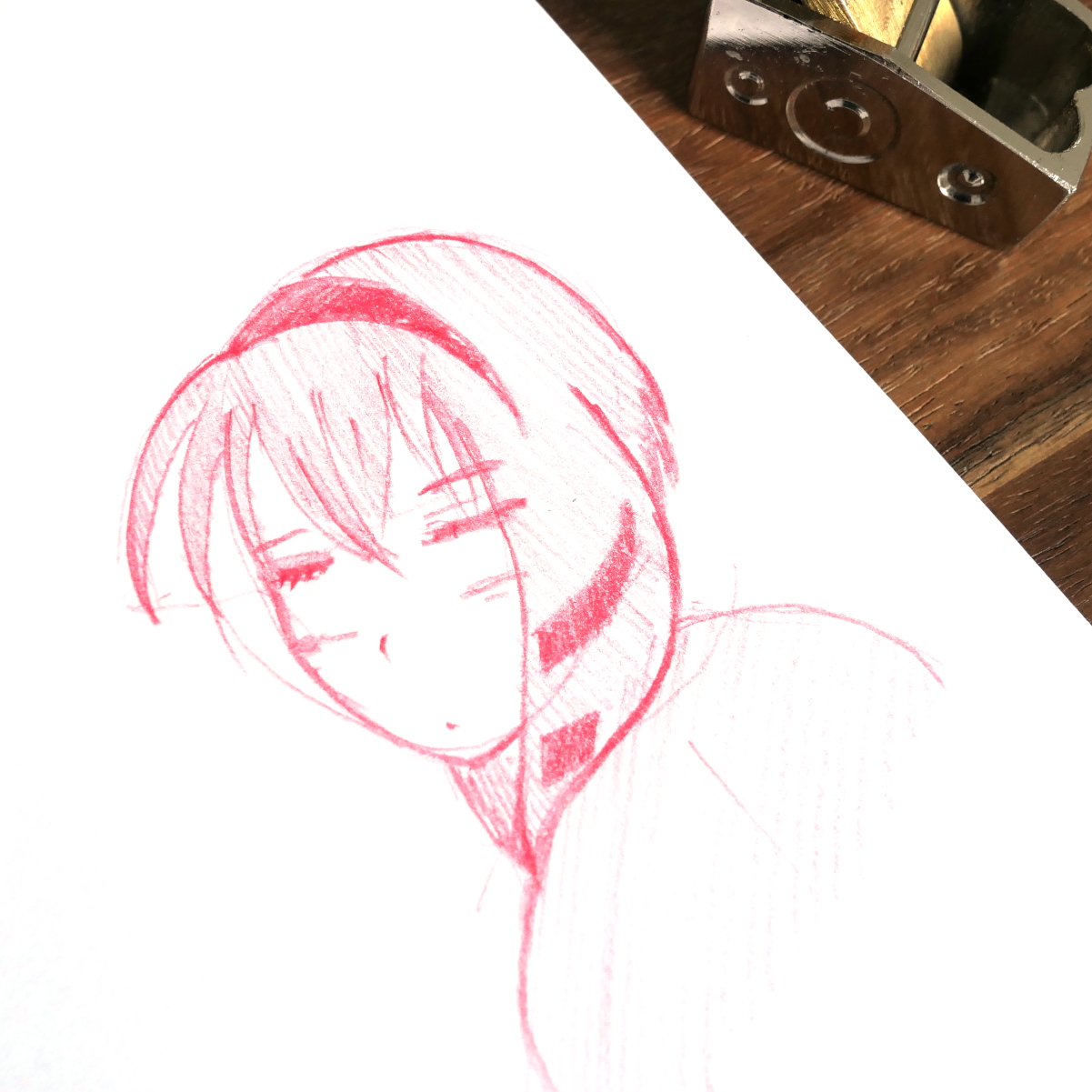Oggi, nella giornata in cui Google Italia decide di celebrare la nascita di
DNA (pace all’anima sua e grazie per tutto il pesce) in Giappone pensano ad altro e fanno i conti con quello che è rimasto.
Il problema della radioattività resta secondario se guardato in sé; il fatto è che la ricostruzione lampo che pareva essere partita subito dopo il disastro non è mai avvenuta. Ricordo bene le foto del prima e del dopo affiancate, a far vedere che in Giappone no, non sono l’Italia; laggiù mica perdono tempo, ricostruiscono tutto.
E invece, nonostante le consultazioni con le università, le valutazioni d’efficacia dei sistemi di decontaminazione e le tecniche messe a punto per portarli a compimento, tutte le operazioni sono in mano alla Kajima Corporation, la più grande impresa di costruzioni del Giappone, che si limita a raccogliere materiale – si parla di decine di milioni di metri cubi – e abbandonarlo in grandi sacchi lungo le strade deserte o a bagnare le strade con le pompe risciacquando le polveri superficiali e impedendo loro di volare ma anche facilitandone la penetrazione nel terreno col rischio concreto di peggiorare irreparabilmente le cose.
La gente è fuggita ma proprio come faremmo noi non regolarizza le variazioni di residenza per non perdere i sussidi statali (come se uno che ha perso la casa e la sua vita di ricordi, affetti, lavoro e famiglia non meritasse di essere aiutato anche se fugge da un’area contaminata da radiazioni; lo biasimereste?) e così intere città sono deserte di fatto ma non nei conteggi ufficiali. Perlomeno si è evitato che il danno si spandesse per anni cone successe a Chernobyl grazie al cibo e all’acqua. Una misera consolazione.
Noi l’abbiamo presto metabolizzato, questo disastro. E’ uno dei tanti.
Sì, ok, è enorme, ma la constatazione terribile da fare è che al giorno d’oggi ogni cazzata è tanto spettacolarizzata da passare sui media al pari delle più enormi catastrofi. Tutto è a livello 10. Tutto è pompato al massimo.
Se oggi un’automobile investe un topo (e tornando a DNA ok, lo so, sono gli esseri più intelligenti dell’universo e sarebbe un vero peccato) la notizia, nelle mani del giusto manipolatore, riuscirà a spodestare dagli onori della prima pagina anche un colpo di stato in Canada.
Io però non me lo dimentico.
Ho pochi amici là, e neanche un paio di settimane fa a 150 km da Tokyo c’è stata una scossa tanto forte che anche i nostri sismografi l’hanno avvertita e monitorata come se fosse stata rilevata sul territorio nazionale.
Era una scossa di magnitudo 6.2, trenta secondi di oscillazioni per i grattacieli della capitale giapponese.
Un tweet veloce, la conferma che non c’è niente di cui preoccuparsi. “Non l’ho neanche sentita, ero in strada e camminavo” mi ha tweetato un’amica. Da non crederci.
Ma Fukushima Daiichi è poco più a nord, tutto è ancora precario, tutto diventerebbe una catastrofe se si dovesse abbattere sulla zona un nuovo sisma o anche un nuovo maremoto con onde appena più alte di quei cinque metri e mezzo di muro che avrebbero dovuto proteggere l’impianto. Per dire, all’isola di Gorgona la scorsa settimana erano segnalate onde di cinque metri e non c’era nessun maremoto.
Ma noi in Italia, oggi, se sentiamo la parola “tsunami” ormai pensiamo solo a Beppe Grillo. E’ un gioco, anche lo tsunami, una cosa da nulla.
Non per me.
C’ho lasciato un pezzetto di cuore laggiù. Ora è contaminato.
E io oggi penso a quelli che non hanno più nulla.
A quella cinquantina di disgraziati che ha condotto le operazioni d’emergenza a disastro appena avvenuto; persone che moriranno male con l’aggravante tutta giapponese del peso della responsabilità. “Eroi” per una visione americana e occidentale della cosa (perché noi siamo plasmati dai film americani e dalla figura dell’eroe che si fa sbriciolare – restando sempre vivo però – per salvare il mondo) ma “Feccia” per la società giapponese che carica loro addosso tutto il fardello dell’inadeguatezza. In un paese dove i treni spaccano il secondo non si premia chi evita i ritardi, perché fa solo quello che deve fare. Figuriamoci se non previene un disastro.
A noi è sembrato di stare al cinema, l’ennesimo film americano d’azione in proiezione per il weekend. Un po’ di gadget, lo spinoff linguistico sui termini “Fukushima” e “Tsunami”, poi si passa oltre.
Ditelo a loro, se avete il coraggio.
Diteglielo senza vergognarvi, che non è stato nulla.
Oggi loro sono là, a sfilare per le strade e dimostrare, come non hanno mai fatto in millenni di storia.
Per la loro salute e sicurezza, per quella dei loro figli.
Per un mondo meno delirante.
Perché la gente non dimentichi.